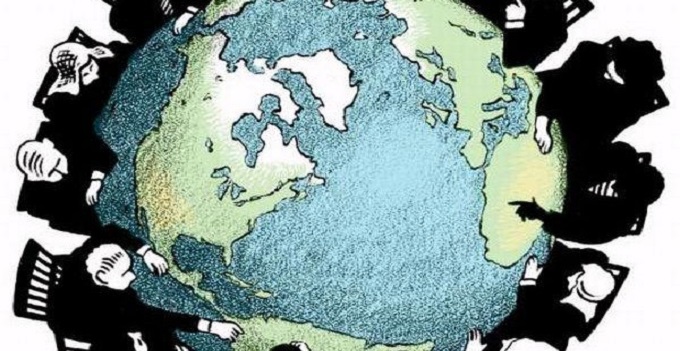
Considerazioni sulla globalizzazione
Il 15 novembre 1975, a 50 chilometri da Parigi, nel castello di Rambouillet, i capi di Stati della Germania occidentale, della Gran Bretagna, della Francia, dell’Italia, del Giappone e degli Usa si accordavano su alcune misure per affrontare la crisi in atto e gli accordi, ormai da tempo superati, di Bretton Woods del 1944. L’anno dopo il vertice si estese al Canada e prese il nome di G7. Questi accordi gettavano le basi della globalizzazione moderna che è cosa ben diversa da quella forma di circolazione di merci, di capitali e di uomini che nella storia era di prassi almeno dalla scoperta dell’America. Se, infatti, non mancò anche a quei tempi una colonizzazione culturale dei popoli con i quali l’Europa entrò in contatto, questa non si spinse al punto da negare ogni specificità, a soffocare ogni differenza, in nome di un melting pot indifferenziato. Spesso, anzi, si assistette a una contaminazione reciproca, a prestiti che, inserendosi su di una identità riconosciuta ed affermata, finivano per essere fecondi di nuovi sviluppi. Religione, mode culturali, usi e costumi dell’ “altro” erano adattati come un vestito su di un corpo diverso; certo, era necessario un lavoro di sartoria, ma non si aveva la pretesa che fosse il corpo a doversi adattare al vestito. Il tutto, intendiamoci, non avvenne in modo pacifico e indolore, ma nella storia ben pochi momenti di crescenza si sono verificati senza violenza. E non si tratta di cinismo, ma di semplice constatazione che nessun parto è indolore. Nella nostra contemporaneità, invece, assistiamo a qualcosa di profondamente diverso; dietro le continue prediche pacifiste e una visione patetica e antistorica dei rapporti umani, coltivata del resto soltanto dal nostro continente e particolarmente in Italia, si verifica un continuo depauperamento della ricchezza culturale che solo la diversità restituisce. Ad esprimere con maggiore pregnanza il contesto nel quale ci troviamo a vivere è forse il vecchio termine di mondialismo che sottende una valenza culturale e meglio segnala il rischio che le identità dei popoli siano definitivamente negate da un pensiero unico appiattito su di una visione economicistica e mercantilistica della vita. La globalizzazione contemporanea, infatti, nasce dall’incontro tra la vecchia globalizzazione economica e il mondialismo culturale, quando ci si rese conto che per il pieno successo della prima occorreva l’imposizione del secondo; si potrebbe perciò usare il termine globalismo. Werner Sombart – a proposito del liberismo economico e della sua ideologia – affermava che il borghese capitalista è un preciso tipo biopsichico, un soggetto affetto da una malattia da speculazione che ne faceva qualcosa di biologicamente alieno dalla normalità umana. La patologia mercantilistica, infatti, concentra, come tutte le nevrosi, l’attenzione psichica su di un unico punto, il potere economico, relegando sullo sfondo gli altri interessi – culturali, religiosi, sociali, ecologici – considerati inutili, stravaganti. Ed è questa, ci sembra, una buona definizione di globalismo.