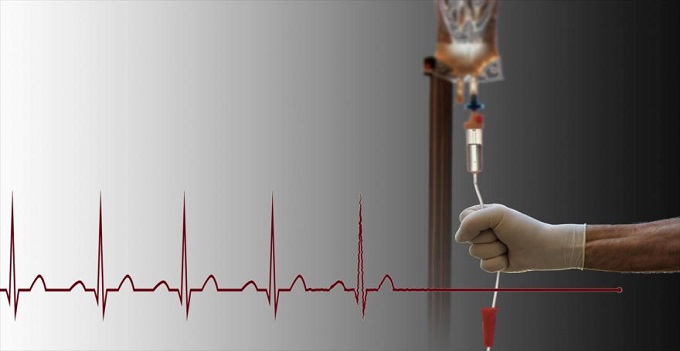
Accanimento terapeutico: di cosa si tratta? [1]
Il criterio etico, guida e riferimento, per le questioni di fine vita deve essere “il vero bene integro della persona“, prestando fede al riconoscimento della dignità che essa incarna, alla sua identità ontologica, il diritto che le spetta a una morte dignitosa nel vero senso della parola, che non è certamente sinonimo di morte inflitta, ma di aiuto al sollievo dal dolore, con attenzione anche alle opzioni, ai rischi e ai benefici possibili delle innovative scienze mediche insieme al bene della società, nell’ottica di una gestione ponderata e non esasperata (sia in positivo che in negativo) delle risorse.
Ciò che gli attori professionisti applicano non è neutro e neppure meccanico in quanto atto della persona umana; così come ciò che il paziente sta affrontando esce dalla nostra concezione temporale, riversandosi in una a-temporalità semantica. Che cosa deve fare allora, il medico? P. Gonzalo Miranda, mio maestro, ha delineato tre momenti, che di seguito provo a spiegarvi in sintesi:
- fare tutto il possibile, quindi adempiere ciò che il medico in quanto medico è chiamato a compiere in soccorso alla salute debilitata del malato, alla vita sospesa di chi soffre; pertanto non può non essere un dovere quello di tentare, senza per questo essere tacciati di estremismo o interventismo, se nel tentativo ciò che si pone in essere si adotta come fine sanare e curare. Provare a compiere quanto è in suo potere cercando di approssimarsi sempre più al vero bene della persona che soffre, evitando banalizzazioni, il cosiddetto “minimalismo passivo“, derivanti da una considerazione impropria del valore dell’essere umano;
- fare solo il possibile:la difficoltà (inesauribile) concreta del nostro problema. Mi è capitata più volte da parte di medici o futuri medici, la domanda “come faccio a capire se quello che desidero iniziare (magari con una ricerca o sperimentazione) o ciò che applico terapeuticamente corrisponde effettivamente al bene della persona?”, è un quesito che tornerà faticosamente ai piedi del letto di ogni malato lungo la loro carriera. Dietro alla domanda si nasconde un’altra formula, più diretta: vale la pena?Si leviga, di volta in volta, la maturazione professionale del medico, chiamato a riconoscere, con umiltà, quando doversi fermare, poiché oltre non si intravvede il beneficio per il paziente, ma solo ostinazione gravosa, e quando continuare o attuare terapie efficaci, alla luce delle risorse scientifiche attuali e delle sue conoscenze. Non è un discernimento immediato e nemmeno semplice, può gettare il medico in profonda crisi, accentuata dal contesto di appartenenza del malato, un “Io” ampiamente articolato, ostico, imprevedibile, scisso e unito fra soggettività e oggettività nell’esperienza del dolore. Bilanciare questi valori, tenendo presente quanto già detto precedentemente, ovvero che l’operato medico non è meccanico, non ripara organi e tessuti, ma agisce sulla persona vivente, unità di corpo, spirito, psiche dove quell’Io abita, implica la non obbligatorietà del paziente e del medico di sottoporsi o di applicare mezzi sproporzionati (uso il distinguo proporzionati/sproporzionati poiché meno esposto ad ambiguità come invece accade con l’accezione ordinari/straordinari), come afferma lo stesso Catechismo della Chiesa Cattolica, del 1992, al n. 2278, “l’interruzione di procedure mediche onerose, pericolose, straordinarie o sproporzionate rispetto ai risultati attesi può essere legittima. In tal caso si ha la rinuncia all’accanimento terapeutico. Non si vuole così procurare la morte: si accetta di non poterla impedire“. La Dichiarazione sull’eutanasia chiarisce ulteriormente, ricordando che “è lecito ricorrere.. ai mezzi messi a disposizione dalla medicina più avanzata (…) ma è anche lecito interrompere l’applicazione di tali mezzi, quando i risultati deludono le speranze riposte in essi“, chiarendo poi che “è sempre lecito accontentarsi dei mezzi normali che la medicina può offrire” e che ” non si può imporre a nessuno l’obbligo di ricorrere a un tipo di cura che, per quanto già in uso, tuttavia non è ancora esente da pericoli o troppo oneroso“, continuando che “nell’imminenza di una morte inevitabile nonostante i mezzi usati, è lecito in coscienza prendere la decisione di rinunciare a trattamenti che procurerebbero soltanto un prolungamento precario e penoso della vita, senza tuttavia interrompere le cure normali dovute all’ammalato in simili casi“. Quanto è scritto si rifà semplicemente al buon discernimento etico e medico, conscio della valutazione di criteri oggettivi e soggettivi, come si può leggere nel testo Cor Unum del 1976, che fa luce sull’importanza di tenere a mente la delicatezza di entrambi questi aspetti e ciò che essi rappresentano concretamente per il vero bene integro del paziente; pertanto si è sempre obbligati all’uso dei mezzi ordinari e proporzionati;
- fare il meglio possibile:“uno sforzo di qualità terapeutica“. Implica per prima cosa garantire le cure normali sempre dovute al paziente, chiamate anche “mezzi minimali” (alimentazione, idratazione, che non sono rappresentano un atto esclusivamente medico, poi ventilazione, cura igienica, medicinali e analgesici idonei, attenzione infermieristica in generale; riporto anche la citazione sulle cure normali della Carta degli Operatori Sanitari n.120, la quale dice che “L’alimentazione e l’idratazione, anche artificialmente amministrate, rientrano tra le cure normali dovute sempre all’ammalato quando non risultino gravose per lui: la loro indebita sospensione può avere il significato di vera e propria eutanasia“) la cui interruzione sovviene alla soppressione del paziente. In secondo luogo evitare le cure che in quella circostanza si rivelerebbero inutili o dannose, applicando il cosiddetto “principio di adeguatezza etica circa l’uso dei mezzi di conservazione della vita“. Quest’ultimo, si struttura in tre fasi: la prima consiste nella valutazione oggettiva degli aspetti medico-tecnici; la seconda nella valutazione degli aspetti soggettivi del malato; la terza il giudizio etico, sintesi delle prime due fasi e loro estensione al dovere morale. Il meglio possibile altro non è che prendersi cura del malato, quindi anche aiutarlo a non soffrire fisicamente e psicologicamente, una consapevolezza oggi largamente presa in considerazione negli sviluppi in ambito palliativo. Accompagnare il paziente e umanizzare il compito medico sono la cornice di riferimento di quanto si definisce “il meglio possibile”.