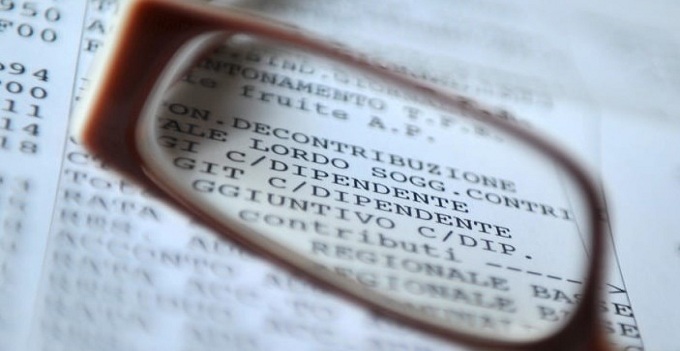
I problemi che pone il salario minimo per legge
Dopo il reddito di cittadinanza, la nuova frontiera affrontata da “5 Stelle” è il salario minimo per legge. La senatrice siciliana Nunzia Catalfo, che è presidente della Commissione Lavoro del Senato, ha presentato, insieme ad altri, il disegno di legge n. 658 che all’art. 2 prevede, per qualsiasi tipo di attività e contratto di lavoro, un compenso orario minimo non inferiore a 9 euro lordi all’ora. Nei giorni scorsi sono iniziate, nella commissione, le audizioni delle Parti Sociali sul merito di questo disegno di legge che è stato preso in esame insieme ad un altro presentato dal partito democratico. Per le conseguenze che questa proposta può avere, svolgiamo alcune considerazioni perché quest’argomento ci sembra somigli un po’ al famoso “mostro del lago di Loch Ness” che ogni tanto riemerge in atti parlamentari.
La questione è in realtà vecchia almeno quanto la Costituzione. L’art. 39 prevede infatti – recependo la preesistente legislazione corporativa – che i contratti di lavoro stipulati dai sindacati abbiano efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alla categoria (cosiddetta validità “erga omnes”): però per la sua attuazione era preliminare la condizione della registrazione dei sindacati e l’attribuzione ad essi della personalità giuridica. Cosa che non è mai avvenuta, per l’opposizione degli stessi sindacati (soprattutto CGIL e CISL) che non volevano nessuna forma d’istituzionalizzazione e di controllo indiretto: pertanto, tutti i contratti collettivi di lavoro sono rimasti atti di diritto privato.
Per ovviare indirettamente a questa carenza, nel 1959 il ministro del lavoro socialdemocratico Ezio Vigorelli emanò la legge n. 741 in base alla quale, pur senza ottemperare all’obbligo della registrazione, i sindacati avrebbero depositato al Ministero del Lavoro i contratti da essi stipulati che sarebbero stati poi pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale. Come in effetti avvenne, ma la Corte Costituzionale – eccependo, giustamente, la mancanza dei requisiti preliminari stabiliti dall’art. 39 – dichiarò ben presto incostituzionale quella legge bloccandone l’ulteriore applicazione.
Da allora, nelle controversie di lavoro i giudici – per stabilire la retribuzione dovuta al lavoratore – si rifecero, e continuano a farlo, all’art. 36 della Costituzione che stabilisce come il lavoratore debba avere una retribuzione “proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro”: il parametro adottato è sempre quello del contratto di lavoro della categoria.
Con il passare dei decenni, però, si sono verificati due eventi.
Il primo, è stata la proliferazione sia di organizzazioni sindacali non collegate alle quattro confederazioni storiche (Cgil, Cisl, Uil e Ugl) sia di piccole associazioni datoriali anch’esse non collegate alla Confindustria e Confcommercio, che hanno stipulato tra loro contratti a condizioni inferiori a quelle esistenti (in particolare, nel settore delle cooperative, dell’edilizia, del commercio) tant’è che il CNEL, cui per legge è affidato l’archivio dei contratti, ne numera circa novecento!
Il secondo, è stata lo sviluppo di tipologie di rapporto di lavoro diverse da quelle tradizionali difficilmente configurabili nei contratti esistenti (pensiamo ad esempio ai “call center”, ai consegnatari di oggetti e cibi ordinati on-line, alle collaborazioni giornalistiche e radiotelevisive, alla gestione dei siti internet, e altri).
Questo ha comportato la difficoltà per il giudice di prendere in considerazione il contratto applicabile in relazione all’art. 36 per la crescita di una giungla contrattuale mentre altri tre milioni di lavoratori, secondo i dati ISTAT e INPS, sarebbero fuori da qualsiasi inquadramento contrattuale. Da qui è nata l’esigenza di stabilire un compenso orario minimo.
Però la cosa non è così semplice, perché farebbe nascere altre problematiche.
Innanzitutto, essendo minimo e uguale per tutte le categorie e mansioni, realizzerebbe un livellamento retributivo senza alcuna attinenza al settore di attività, alle mansioni svolte, alle modalità di svolgimento del lavoro, al territorio. Inoltre, considerando che la media di ore lavorate in un anno a tempo pieno è di 2000, ne conseguirebbe una retribuzione annua lorda di 18.000 euro: tenendo presente la quota parte di tredicesima, dovuta per legge, e le trattenute fiscali e previdenziali, risulterebbe una retribuzione mensile di 1.100 euro circa, che molti contratti vigenti non prevedono per alcune categorie di lavoratori. E, infatti, già le associazioni datoriali hanno ammonito il rischio di un aumento dei costi mentre Andrea Garnero, economista dell’CSE, nella sua audizione parlamentare ha detto che l’importo previsto dal disegno di legge “sarebbe tra i più elevati dell’area OCSE”.
Ma vi è anche un altro pericolo: la fissazione di un salario minimo per legge indurrebbe qualche associazione datoriale a non stipulare più contratti collettivi di lavoro. Il che non sarebbe solo un danno per i sindacati, come si è scritto, perché nei contratti si stabiliscono molte altre normative a favore dei dipendenti migliorative di quelle previste dalla legge. In particolare, negli ultimi anni si è sviluppato il cosiddetto “welfare aziendale” che interviene per integrare le spese mediche e la previdenza insieme ad altri interventi quali la corresponsione di una partecipazione alla produttività e ai risultati d’esercizio: tutte cose che svanirebbero dietro l’alibi del salario minimo di legge. E i sindacati hanno fatto presente che “l’introduzione del salario minimo per legge finirebbe per gratificare le aziende che concorrono con le altre agendo esclusivamente sul costo del lavoro”.
Vi sono quindi due considerazioni finali su questa proposta. La prima: insieme al reddito di cittadinanza e alla pensione di cittadinanza, essa risponde ad una concezione egualitaria della vita economica, assai simile al comunismo teorico, propria del Movimento 5 Stelle in quanto lo Stato considererebbe le persone tutte eguali stabilendo per esse l’importo della paga, della disoccupazione, della pensione, ignorando tutta la varietà e la specificità del lavoro, delle competenze, dell’impegno personale e la libertà economica. La seconda: la finalità ulteriore, anche se i proponenti non se ne rendono conto, è quella di pianificare per legge, rendendolo stabile, il costo del lavoro lasciando inalterati tutti gli altri parametri, abolendo così ogni ipotesi di partecipazione agli utili e alla produttività.
Non sappiamo che esito avrà questa proposta, ma i pericoli insiti in essa sono quelli qui esposti.