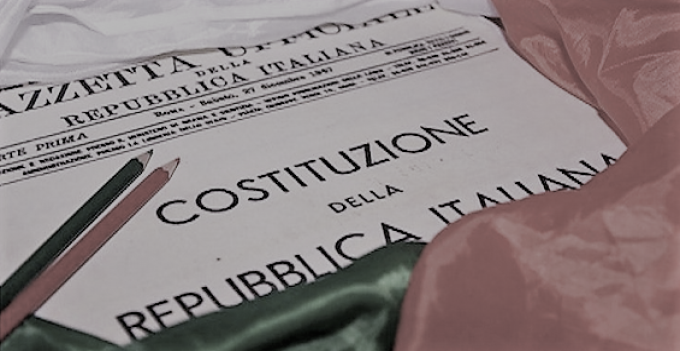
La Costituzione e il “mito” dei diritti inviolabili
In più di anno dall’entrata in vigore della deliberazione del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020 sullo “stato di emergenza” di rilievo nazionale abbiamo, in più di un’occasione, invocato la compressione o il non proporzionato bilanciamento dei diritti contemplati dalla Costituzione repubblicana vigente. Ora, la teoria secondo la quale la previsione, da parte del decreto-legge, di misure di contenimento elastiche attuate e modulate dai vari decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri pro tempore non costituisce un modello contrario al Testo fondamentale, non mi pare convincente.
Infatti, il suo accoglimento implica che il bilanciamento effettivo dei diritti venga lasciato ad una fonte secondaria di produzione del diritto non sottoposta ad alcun controllo preventivo di legittimità fatto salvo l’obbligo di informare i due rami del Parlamento. È arrivato, però, il momento di sollevare il velo di Maya di schopenhaueriana memoria: restituire un’immagine ben lontana da quell’idea di corazza, di trumps (Dworking), di perentorietà e inviolabilità che dei diritti tradizionalmente si ha. Nel costituzionalismo contemporaneo questi non solo sono deboli già nelle loro formulazioni testuali con l’indicazione di limitazioni vaghe e volutamente generiche, ma sono anche agevolmente superabili sia in sede legislativa (e amministrativa), sia in sede giurisdizionale in vista della protezione di altri diritti o interessi pubblici. Detto diversamente, l’indefinita bilanciabilità dei diritti (sul punto si rinvia alle considerazioni di Aleinikoff e Webber) li rende fragili e sottoposti alla volontà politica di chi in un dato momento storico detiene il potere politico. I diritti, allora, non possono trovare il loro fondamento né nella norma agendi (la legge, per dirla con Giuseppe Bettiol, è causa formale, non sostanziale del diritto), né nella soggettività giuridica formale (il diritto di avere diritti), bensì unicamente nella giuridicità, ossia nella conformità alla loro fondazione morale che trova nell’essere il suo presupposto.
Non si può, allora, condividere il pensiero di Hans Kelsen (1881-1973) che nega la derivazione del dover essere dall’essere, in quanto il suo ragionamento presuppone una visione meccanicistica di ciò che è e non prende invece in considerazione il piano dell’essenza. E quand’anche si volesse negare questo dato si cadrebbe in contraddizione: bisognerebbe cioè dimostrare che l’uomo non ha una sua natura che lo spinge verso un determinato fine e che gli è indifferente essere ciò che è oppure un’altra cosa. Come scrisse Tommaso d’Aquino (1224-1275): «Non videtur esse lex quae iusta non fuerit».