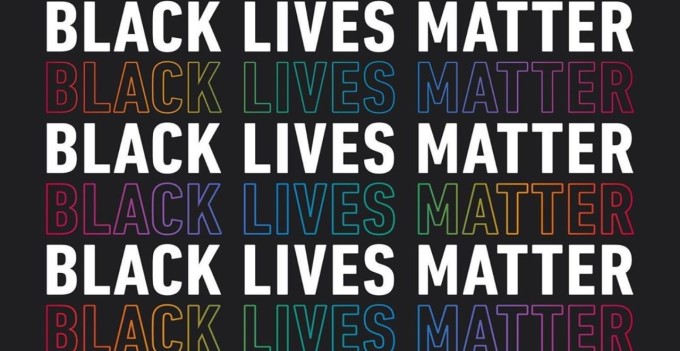
APPROFONDIMENTI: Fermate il mondo, voglio scendere
Black lives matter? Sbagliato. Human lives matter.
Il problema è tutto qui.
Da questo volontario e mefistofelico equivoco continueranno a discendere senza fine immani distorsioni, che alimenteranno, come già stanno facendo, nuove “religioni della colpa in assenza di inferno e di paradiso”. Ve ne sono già molte. Ne saranno fondate presto delle altre. Quella che ora va per la maggiore è quella il cui credo recita “i bianchi hanno la colpa metafisica di aver oppresso, schiavizzato e depredato i neri, e con essi moltissimi altri popoli che hanno osato dichiarare inferiori, e per questo dovranno espiare la loro colpa tramite la perenne professione di inadeguatezza, malvagità e flagellazione del proprio spirito, diminuendosi, umiliandosi, inginocchiandosi”.
Ha colpito dritta al cuore l’immagine di una bambina, sollecitata dai genitori ad esibirsi in questa parodizzazione di un autodafé, inginocchiata con un cartello in mano con sopra scritto l’ormai nuovo Simbolo Minneapolitano – Black lives matter – e una grossa freccia indicante la sua testolina bionda con una scritta multicolore – PRIVILEGED -.
Come si fa a non vedere, pur animati di tutta l’umana comprensione, quanto tutto questo si fondi su un paradigma ancor più razzista, od anzi! Sarebbe ora di dire razzistoide, per differenziare una volta e per sempre il razzismo, quale teoria scientifica definitivamente falsificata che vede i suoi albori nell’accecante bagliore dell’Illuminismo, da tutte le sue resurrezioni pretestuose in chiave prettamente ideologica e anti-scientifica.
Ritenere che oggi esista, realmente, un pregiudizio di ordine razziale alla propria autorealizzazione, alla costruzione del proprio benessere, al riconoscimento della propria dignità di esseri umani, e sostenere che questo pregiudizio spieghi tutto (parola che non si dovrebbe usare mai) significa svolgere una semplificazione ideologica della realtà allo stesso modo di chi ritiene che tutti i problemi dell’Occidente storico, o dell’Europa, e di altri paesi siano derivati dall’immigrazione.
Tutti, a pari merito: i talebani progressisti (che in nulla progrediscono), che strumentalmente vogliono dipingere il mondo come perennemente governato da nazisti, fascisti, razzisti, sessisti, paternalisti-etero-patriarcali, omofobi, transessuofobi e clericali; e i talebani conservatori (che non conservano un bel niente), che vogliono infarcire la realtà passata e presente di narrazioni leggendarie altrettanto astoriche rispetto a quelle progressiste, citando una stalattitica Tradizione, salvo poi non parlarne affatto, impugnando il crocifisso a cottimo, giusto il tempo di difenderne la presenze nelle aule scolastiche, delirando di etnie, stirpi, discendenze, etiche cavalleresche, dogmi di fede, vagheggiando purismi, che come urobori si divorano vicendevolmente, ognuno invocando un purismo più stringente dell’altro. Hanno buon gioco i lettori idolatri di Simone Weil e Frantz Fanon (che leggono solo questo e poco altro), contro i lettori idolatri di Spengler e Huntington (che spesso, in realtà, non leggono affatto), e viceversa.
In questa, che Marx ed Engels nelle loro opere avrebbero probabilmente derubricato ancor oggi a “guerra delle frasi”, o “guerra contro i simboli dell’oppressione e non contro l’oppressione medesima”, nessuno se non poche e marginalizzate intellighenzie si permettono di domandarsi se il fenomeno della discriminazione abbia delle ragioni di ordine socio-economico. D’altra parte è complesso e impegnativo sciogliere i nodi di convergenza tra atteggiamenti discriminatori di tipo socio-culturale e contesto materiale. E’ molto più semplice esporre una bella bandiera arcobaleno, da una parte, e invocare il grande vecchio Kalergi dall’altra, per mettere a tacere ogni interrogativo con esaustive “teorie del tutto”. Nessuno ha gridato che le vita umane avevano valore, scatenando l’inferno, quando Elon Musk, fondatore di Tesla, ha minacciato gli operai dei suoi impianti in California di tornare a lavorare nonostante la chiusura causa covid-19, pena non ricevere alcun stipendio. Allo stesso modo, nessuno ha iniziato a inginocchiarsi dopo la notizia riguardante la condotta da caporalato di Uber in Italia, che sfruttava e vessava i propri “cottimisti del pacco” con ritmi disumani anche durante le misure di isolamento sempre causa covid-19. Non ci sono mai stati afflati iconoclasti (che per essere coerenti dovrebbero almeno essere rivoluzionari) per tutti coloro che sono morti perché aderenti ad una fede religiosa, perché sottoposti a ritmi di lavoro massacranti, perché non in possesso di un’assicurazione sanitaria, o perché, nel protestare per una giusta causa, non avevano patroni abbastanza influenti dal salvaguardarli da rappresaglie armate.
Questi sono esempi banali, approssimativi, al più anche incosistenti. Sono una superficie appena sfiorata di contraddizioni. A nessuno sembra aver balenato nella mente che le condizioni di diseguaglianza ed emarginazione sociale della popolazione nera (ma non solo) negli Stati Uniti d’America sia dovuta alla mancanza di politiche pubbliche welfaristiche, e quindi di politiche sociali in favore di istruzione e sanità prima di tutto, e che i rigurgiti razzistoidi e l’abuso di potere da parte delle forze dell’ordine siano l’epifenomeno di un fenomeno complessivo ancor più grande che si chiama capitalismo? Non pare curioso che coloro ad essere più bistrattati, bastonati, abusati, emarginati siano anche abbastanza indigenti? Ma non sarà che un’esigenza strutturale, di sistema, usa la bieca eco di una propaganda razzistoide per far restare i rapporti di forza economici inalterati? E che questo stesso sistema preferisca di gran lunga sposare una causa che nulla inerisce la concreta e materiale distribuzione della ricchezza? Inginocchiarsi non costa nulla, la collettivizzazione dei mezzi di produzione un po’ di più (boutade).
Sovviene il candido schieramento con Black Lives Matter della Chevron Corporation, la quale, così, si è messa dalla parte giusta della storia, mentre tutti possono comodamente ignorare i suoi eco-crimini nei confronti della popolazione dell’Ecuador e della Nigeria. Ed è altrettanto chiaro quali sono i limiti che questi nuovi paladini della giustizia sociale non devono assolutamente permettersi di sorpassare: e la foto di Abercrombie & Fitch, che davanti i propri stabilimenti ha sostituito il picchetto d’onore di torsi nudi scolpiti ed efebici con soldati in tenuta anti-sommossa , si direbbe lo lasci ben intendere.
Ma anche queste sono banalità, increspature sulla superficie. La questione è più profonda e ramificata: necessita a suo carico statistiche, trattati generali, analisi differenziate e su scala, tutte cose che chi scrive qui non può fare. Il punto è che, sempre chi scrive, ha l’ottimistica presunzione che certe cose, per citare gli amici anglosassoni, siano self-evident. Nel loro spirito almeno, esse sono capaci di travalicare le narrazioni di maniera e arrivare per quello che sono: contraddizioni, cortocircuiti. Non solo la popolazione nera, che gioca egregiamente la partita del divide et impera nel ruolo di pedone, ma popolazioni di ogni colore appartengono a fasce di reddito trasversali per tutto il globo che soffrono la polarizzazione della ricchezza, l’abbattimento delle garanzie contrattuali, i tagli al welfare, le delocalizzazioni, il blocco dell’ascensore sociale e dei salari. Seppur consistenti in una loro fenomenologia complessa ed importante, risentimenti razzistoidi e immigrazione di massa nascondono rispettivamente, pur con le loro drammatiche realtà umane, due ben strutturate esigenze sistemiche: livellare sulla contrapposizione autoctono/diverso il dibattito pubblico su lavoro, occupazione, reddito; e garantirsi una riserva di manodopera a basso costo che possa erodere le conquiste sindacali e nel contempo ricoprire ruoli di manovalanza che una società sclerotica ha smesso di valorizzare e tutelare (per sfornare migliaia di laureati in scienze della comunicazione). Tutto il peso di questa seconda esigenza viene scaricato su sistemi di welfare le cui maglie legislative, originariamente concepite per i cittadini, sono così ampie da applicarsi ora a tutti gli individui residenti sulla superficie nazionale, quale che sia. Nessun problema, visto che la conflittualità sociale che ne scaturisce viene riconvertita in consenso elettorale per forze politiche dichiaratamente anti-immigrazioniste e altrettanto fermamente indisponibili a qualunque riforma economica sostanziale. Il meccanismo è ben oleato e funziona perfettamente.
Se i talebani progressisti questo non lo vogliono neppure lontanamente vedere, i talebani conservatori non lo capiscono affatto. Colui che con tutta la buona volontà volesse provare a spiegarglielo in termini economicistici, i quali sarebbero ampiamente bastevoli per carpirne la profonda e perversa ingiustizia, non avrebbe alcun successo se, ad un certo punto, arrendendosi, non si mettesse a citare Evola (tutti lo citano, nessuno lo legge) per poi parlare del modello degenere rappresentato dalla società multiculturale. Allora inizierebbe un’imbarrazzante e stomachevole palinodia, in cui tutti i presenti, colmi di contrizione, si scuserebbero per non aver capito quale altissima critica si voleva muovere e non si attarderebbero a concordare: il modello multicultare è il nemico. Certamente: perché questo modello capitalistico, anche se non si macchiasse del crimine di produrre società multiculturali, sarebbe un santo? L’ottima sintesi è: ai talebani conservatori non interessa alcunché dello scenario economico in cui sono immersi, ma guai a rovinargli l’Arcadia delle vacanze estive con il richiamo di uno scuro avventore dal sorriso smaltato che grida in lontananza “Coccobello!”.
Il multiculturalismo è un’ingegnerizzazione sociale che si può fare a tavolino fino ad un certo punto; come tutti i contesti multiculturali, anche quelli odierni si sono formati per cause materiali (fra cui quanto sopra). La grande differenza è che, rispetto al passato, le entità statali quali che fossero non solo governavano e organizzavano il processo, ma tendevano ad incoraggiare anche percorsi di assimilazione e convivenza virtuosi affinché il multiculturalismo non sfociasse in ghettizzazione, anarchia, etnicizzazione dei conflitti sociali. A tutt’oggi, il repubblicanesimo, in realtà statali più decise, sembra la via migliore per ricucire le fratture sociali attorno ad una lealtà ai valori istituzionali, poiché la politica di valori e simboli non può fare proprio a meno, per quanto all’acqua di rose. Ma ad oggi, nella maggior parte dei casi, il multiculturalismo è diventato il feticcio su cui le democrazie liberali devono giocarsi la propria credibilità, dal momento che lo stato democratico (sedicente tale) non è più in grado di mantenere le proprie promesse originarie nei confronti degli stessi cittadini. Così, per sgravarsi dell’obsolescente apparato dei diritti sociali, tramutati in un semplice tavolo negoziale dove si decide a chi, di legge di bilancio in legge di bilancio, andranno un po’ di pensioni, sgravi fiscali, assegni di mantenimento, redditi minimi, redditi di disoccupazione, ecc, si sposa appieno la battaglia di nuovi, stravaganti e inconsistenti diritti civili, i quali pongono al centro la diversità come valore intrinseco, non dubitale, non criticabile, e ipso facto il più importante principio costituzionale (quale che sia la costituzione).
Da qui ritorniamo al connubio tra questa visione e quella per la quale il mondo, da quando il primo re-sacerdote sumero ha vergato su una tavoletta di cera l’unità di misura con cui fissare il tributo in granaglie per i contadini, sia governato da nazisti, fascisti, razzisti, sessisti, paternalisti-etero-patriarcali, omofobi, transessuofobi e clericali. Tutte categorie che servono a indicare come, alla fin fine, guardando in retrospettiva il mondo dal 1789, ossia da quando si è iniziato ad affogare i preti nelle acquasantiere, la storia del mondo è stata una perenne insurrezione contro l’autorità, che è naturalmente il male assoluto. Non ha importanza cosa ci fosse in ballo: i contesti economici, sociali, religiosi, filosofici, antropologici, questa è roba per chi ha voglia di perdere tempo all’università.
La storia del mondo è un tutto presentificato: chi si ribella ha sempre ragione, perché ci si ribella sempre all’autorità, e l’autorità è sempre malvagia, perché origina da una fonte numinosa e indistinguibile, incontrollabile. Si intreccia col sentire più profondo dell’uomo, con rappresentazioni collettive primordiali, sulla forma senza sostanza che il è potere (Neumann), che inevitabilmente trascende l’esistente, irriducibile a qualunque positivizzazione. L’ineluttabilità del potere, e quindi della politica, rappresenta il fondamento di quel logos teologico-politico, che è il discorso per eccellenza attorno a cui si sono fondate le civiltà. L’origine del potere, il mistero della sovranità, è l’interrogativo massimo su cui all’alba di ogni sconvolgimento ogni comunità politica ha rifondato se stessa. Ma d’altra parte questa politica, di cui tutti parlano da millenni, che cosa ha prodotto? Guerre, morti, fame, ignoranza, miseria, genocidi, oppressione e così via. Quindi bisogna liberarsi di questa politica dalle origini numinose, va materializzata, razionalizzata, meccanicizzata e circoscritta. Da Hobbes in poi, con le mille sfumature del caso, non si è fatto altro che questo.
E quindi qual è quell’attività degna di contrapporsi alla politica, il male necessario smithiano? L’economia naturalmente: la quale è un’attività competitiva pacifica, crea benessere e servizi, progresso, sviluppo, connette contesti lontani e li unisce in interessi comuni. La visione di un mondo pacificato tramite la neutralizzazione degli scenari politici (e quindi bellici o generalmente conflittuali) in favore della libera competizione economica, visto come fenomeno irenico, nasce e si sviluppa nel XVIII secolo. Mai totalitarismi così terrificanti furono concepiti prima della penna dell’Abbé Saint-Pierre, e poi di Immanuel Kant. Impallidiscono le ambizione gattinaresche alla monarchia universale di Carlo V, dinnanzi ai progetti di paci perpetue di tali autori, che auspicavano un mondo retto secondo interessi meramente economicistici, amministrabile comodamente tramite un diritto universale prestabilito e non bisognoso di alcune modifiche. Un mondo dove la politica, la mediazione dei rapporti di forza, l’ineliminabile volontarismo che deve farsi carico di tutte le istanze governabili, viene commissariata e spartita banalmente tra l’utile dei mercanti e il giustiziabile secondo la legge scritta, il tutto annacquato dalla conveniente finzione rappresentativa del regime elettoralistico-democratico.
A tutt’oggi, questa è un’idea di mondo che viene scientemente perseguita, a dispetto delle incalcolabili riprove che l’economia, come macro-processo umano, ha le mani sporche di sangue tanto quanto la politica. Essa è stata per certi versi assai più pervasiva, oppressiva e spietata, proprio a causa della sua presunta meccanicità, ossia mancanza di espressa volontà di opprimere. Qualunque guerra, predazione, massacro, ingiustizia e privazione l’economia abbia ingenerato, è sempre il danno collaterale di una macchina perfetta, “la mano invisibile” del mercato; solo la politica irregimenta i busti sui balconi piegando la volontà dei popoli ai loro desideri, e solo quella si è vista e si vuole vedere.
Non sorprende, allora, che di fronte a questa visione del mondo dalla violenza inedita, intenta a distruggere la forma del potere teologico-politico europeo, studiare la Storia non serva più. È inutile. Essa non è altro che il lungo elenco delle malefatte dell’essere umano corrotto e ignorante prima che venisse illuminato dalla ragione, vale a dire la ratio economicistica, razionale-scientifica e conseguentemente materialista. Neppure la Filosofia serve più, o se serve, serve solo per spiegare anzitutto che la logica mercatistica è un dato di natura, e non un prodotto artificiale; che il capitalismo esisteva dall’età della pietrà, erano gli ominidi che non lo sapevano; che quindi l’essere umano è malvagio e bestiale, ed è animato da una natura antisociale ed acquisitiva, che si consocia con i simili solo per il suo utile; che i rapporti economici non sono rapporti di potere, ma sono semplicemente la differenza che intercorre tra chi prendeva lezioni di economia all’oratorio e chi aveva il life coach della Pantene, che gli diceva tutti i giorni “tu vali”; che la religione è una banale forma di eziologia pre-scientifica per spiegare i fenomeni naturali, e, nel dubbio, anche l’oppio dei popoli.
Ergo, tutto l’ordine del mondo che è stato costruito a partire da qualunque fondamento che non fosse fra questi è per sua stessa natura etichettato come reazionario, nazista, fascista ecc, ecc. Ogni espressione che diverge da questi presupposti è passibile di diventarlo in ogni momento. L’arte, la simbologia, il diritto, la letteratura, l’epica, ma recentemente anche la biologia, e non c’è motivo di credere che presto non ci si spinga alla fisica o alla chimica; tutte forme di scrittura dell’intelligenza umana rivedibili, se corrotte dai mali (per esempio) dell’etno- o dell’eurocentrismo.
Nell’arte questa coltre censoria è ben rappresentata dalla soffocante musealizzazione. La trasformazione dell’arte, quale tensione spirituale umana, espressione vitale e dinamica della coscienza, in “bene culturale”, dotato di valore convenzionabile. Arte che è ridotta, da testimonianza olistica di un tempo e di uno spazio, a neutrale “prodotto del genio umano”, buono per tutte le domeniche e per tutte le famiglie, con biglietto ridotto ai minori. L’arte è prudentemente svuotata dall’aggressività del suo linguaggio, barricata dietro le mura di tracotante saccenterie delle guide museali, della noia asfissiante dei depliant delle agenzie di viaggio, della religiosa ortoprassi deambulatoria e contemplativa tra le teche, accompagnati da torme di giapponesi in t-shirt. Posti in un simile contesto, quale potere comunicativo possono avere il Discobolo di Mirone, il Doriforo, o i Bronzi di Riace? Nessuno. Ed è certo bene così, perché se “l’hitlerismo”, come scrive Simone Weil, è tranquillamente rinvenibile negli antichi romani, nulla vieta che qualcuno veda il seme del nazismo nel Doriforo o nei Bronzi di Riace, o addirittura nelle cariatidi del Partenone (ancorché sia più probabile che il Partenone sia sessista, questione di sfumature). Al di fuori della sua dimensione monetizzabile, un Bronzo di Riace come veicolo dello spirito artistico, di una tensione umana, di un’espressione di civiltà è assolutamente irricevibile.
Qualcuno, penserebbe un militante dell’Arcigay, potrebbe credere che il Bronzo di Riace rappresenti una visione auspicabile dell’uomo, l’uomo nella sua naturale virtù, nella sua intrinseca bellezza. Assolutamente impensabile! Il chiasmo di Policleto non può permettersi di esprimere una visione olistica dell’Uomo (guai tendere all’assoluto o all’universale). Anzitutto perché il Bronzo di Riace è maschio, quindi è una statua sessista (chiaramente); dopodiché è tornito, alto e barbuto, quindi è non solo tradizionalista, ma pure omo- e transessuofobo, perché lede il diritto sacrosanto, per esempio, ad un omosessuale di media bellezza, con la pancetta alcolica, e che magari condivide con l’imperatore Eliogabalo l’interesse per gli abitanti della mauretania (se non è una superfetazione razzistoide questa), di riconoscersi in armonia con la realtà che può essere solo quella del suo desiderio.
Quindi è chiaro che chi ha questa visione del mondo, di una ferocia ideologica che non ha nulla da invidiare alla stessa determinazione con cui certi scienziati hanno definito le popolazioni negre dell’Africa come non umani o meno umani, veda nel razzismo (per ritornare ai Black Lives Matter) il feticcio con cui perpetuare lo smantellamento sistematico, non solo dell’identità, concetto ancora molto fumoso e frammentario, ma dell’intera storia europea come entità residuale di tutti i processi (perché lo è). Dal che ne consegue, naturalmente, che ogni statua rappresentante un personaggio del passato sia irricevibile. Non ha neppure molto più senso dare una dimensione storica a parole come nazismo e fascismo, visto che intellighenzie coltissime hanno fatto l’impossibile per sdoganarne l’astoricità: dopo Simone Weil, Umberto Eco ha proposto la teoria dell’Ur-fascismo. Quindi anche la statua di Robert Bruce, re di Scozia tra i secoli XIII e XIV, era potenzialmente fascista. Anzi, sicuramente: era un re, era cattolico, aveva combattuto guerre e viene pure raffigurato con una spada in mano. Se l’è praticamente cercata.
Perché la furia iconoclasta? Perché probabilmente aveva ragione Erich Neumann, quando paventava la “disintegrazione del canone archetipico” nella coscienza collettiva. Ma rimanendo su dimensioni più vicine al conscio, è sommamente in crisi la rappresentanza e la rappresentazione di noi stessi ordinati in una dimensione universalistica o ugualmente vasta, di portata comunitaria. Per questa ragione la Verità è diventata sinonimo di arbitrio, e opinione di libertà. La proiezione egoica sul mondo dell’uomo contemporaneo è così superba e pretenziosa che non sopporta più, non solo le forme rappresentative politico-sociali (finanche quelle giuridiche), ma anche quelle artistiche e filosofiche. Anche parlare “in generale” sta diventando una pratica oggetto d’intolleranza, poiché in ogni caso rimanda ad una sorta di dimensione conoscitiva collettiva. Parlare in generale è il discorso politico per eccellenza, richiama la condivisione di fenomeni che attengono una medesima cultura materiale, un contesto geo-storico comune, astraendo dal singolo. Il discorso generale (e non generalizzante, si badi bene), è il discorso comunitario. Quindi ogni cosa che non comincia con le formule “secondo me, la mia opinione è, a parer mio”, tutte espressioni massimamente relativistiche, suonano agli astanti come un’imposizione, una “violenza retorica”, un “fascismo epistemico”. In inglese, sui forum, esiste un acronimo utilizzatissimo dai millenials, IMHO, ossia “in my humble opinion“, che rende bene l’idea della nuova etica del dibattito: più mortifichi la tua idea, relegandola all’irrilevanza, più sei degno di essere ascoltato. Più sostieni di dire sciocchezze più sei elogiato per la tua falsa umiltà.
Questa modernità non ha smarrito il telos, non lo vuole proprio più. Non sono in crisi le identità (poco male, se ne creerebbero delle altre), non è più necessario averne una. La storia finisce quando se ne perde il senso (Fukuyama, a confronto, era un dilettante). I processi di produzione, potenziabili ad libitum dallo sviluppo tecnico, hanno fatto piombare l’intera contemporaneità in una meta-alienazione: non la semplice estraneazione dovuta al lavoro, che pure sperimentiamo, ma l’estraneazione dai processi di produzione stessi, ossia l’assimilazione dello scenario antropico a dato di natura. Non c’è più bisogno di discutere della storia del caffé per spiegare perché si trova nella tazzina in polipropene dopo pranzo; dei processi, delle energie, delle volontà politiche che lo hanno permesso, dei capitali mobilitati, della logistica; tutto questo è ridotto alla stessa certezza con cui sorge il sole; che la tazzina esista e il caffé macinato pure, è molto più sicuro della tua possibilità di guarire da una grave malattia in un ospedale pubblico.
In tal senso la modernità si va disegnando come un processo che si auto-legittima in ogni momento in quanto è. E’ puro volontarismo desiderante assolutamente avulso a qualunque significazione del tempo che non lo veda come il momento più alto, e libero. Le contraddizioni del passato, la complexio oppositorum (da Cusano a Carl Schmitt), sono una terribile e insostenibile responsabilità metafisica, di cui pur di non essere costretti a farsi carico, si preferisce raschiarla via in nome di un’altra metafisica della colpa, travestita da critica etnocentrica della cultura. Questo è il prodotto della meta-alienazione: «ho l’I-phone, ho Alexa, Netflix su tre schermi in HD, l’Home Banking, la Nintendo Switch, ma si può sapere a me a cosa mi serve conoscere l’Etica Nicomachea? Ma abbassate le tasse!».
Il mondo non ne può più di andare a scuola e aprire un libro su Aristotele. Perché Aristotele (e come lui chiunque altro, ma Aristotele lo conoscono tutti) ha questo bruttissimo vizio: vuole dare ordine alla realtà in modo univoco e universale, ci vuole dire chi è l’uomo, cosa deve fare, come deve pensare, cosa è vero, cosa non è vero, cosa è vero per lo più, cosa è pathos, cosa è ethos, cosa è scienza, cosa è doxa. E’ ora di finirla! Uno come Aristotele non è più potabile: è greco, è un conservatore “idealista”, parla di Dio, di Stato, di Morale, possiede schiavi. Decisamente antiquato. Oggi c’è bisogno di un bell’influencer genderfluid che legge solo storia di genere, che alga su un palco e dica: “io mi sono fatt* un po’ una la mia religione, perché ho comunque una forma di spiritualità, ma penso che ognuno possa fare quello che vuole. Peace and Love“. Di questo c’è bisogno. E quindi il razzismo (ritorniamo ancora ai Black Lives Matter), la lotta contro di esso, anche laddove purtroppo questo razzismo si è preservato nei suoi caratteri storici più forti, come negli USA, è un acceleratore sociale che serve per dirci quanto ancora la civiltà europea (che ricordiamo essere un unicum di bastardaggine e contaminazioni) faccia talmente schifo che tutto sommato, fanno proprio bene questi a prendere il mondo a sprangate. Perché, finalmente, se dopo tutto quelle sprangate, finalmente non sentiremo parlare più di Aristotele, saremo davvero liberi.
Un ultimo e disperato ammonimento giunge infine: Ma quale eurocentrismo? Quando la più grande colonizzazione della forma è stata lo Stato moderno e la forma economica capitalista? Come si può parlare seriamente di diversità, e lotta allo spirito coloniale, quando nei fondamenti l’intero mondo si riconosce negli universali razionali che gli ha imposto la potenza militare europea? Ma quale critica relativistica che valorizzi la diversità e la multiculturalità si può fare, quando tutte le proteste sociali di volta in volta sono animate da perfetti consumatori meta-alienati e occidentalizzati? Non parlate come se in piazza ci fossero gli aztechi del 1521.
In ogni caso, se si continua così, vince di nuovo Trump.