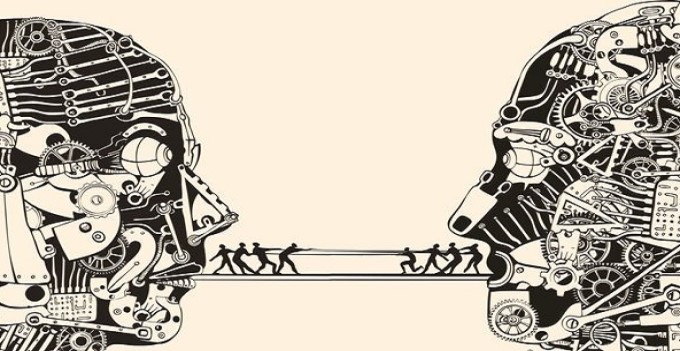
Ci deve essere una legge (che potrebbe essere, per me, ignorante, la quinta della Termodinamica), per la quale se una qualsiasi macchina assorbe una quantità di energia infinitamente superiore a quella che essa eroga per il servizio che le é stato assegnato, ciò significa che tale macchina, fatta eccezione per degli scarti infinitesimali, ‘pensa’ solo ed esclusivamente al proprio funzionamento, e che, in un mondo intimamente interconnesso come il nostro, questo é un delitto.
La Fisica e la Morale, che si é usi immaginare ‘sparpagliati’, secondo il modo di dire di Pappagone, talvolta sono ‘vincoli’, e ciò accade quando esse s’incontrano nel demanio della Politica, il solo posto dove avvenga l’atto di disperdere meno energia di quanta se ne consumi – come un piccolo colpo di tosse al termine di un’operazione in cui si é processato l’uragano – e dove, tuttavia, tale spreco sia soggetto ad una valutazione di ordine morale: che normalmente rimane lettera morta, quando non prorompa, poderosa, in una manifestazione di violenza, come in Francia nel 1789, in Russia nel ’17, o in Italia nel ’22.
E’ possibile che una legge del genere accennato esista come un implicito corollario di altre leggi, come quella di Lavoisier, e che in ogni caso siano state fissate delle sanzioni per qualunque cosa contravvenga all’obbligo di adeguarsi al fiscal compact della natura (tanto, esce, tanto entra…) o per qualunque organismo politico che si comporti in maniera parassitaria trattenendo dentro di sé quasi tutto ciò che gli viene corrisposto perché poi provveda a rimetterlo in circolo.
Sono convinto dell’ineluttabilità del castigo come conseguenza di unn eccesso solo allorché si tratti di eventi naturali, ma che sia preferibile parlare di semplice ‘compensazione’ in relazione a quelli circoscritti al mondo degli uomini, posto, comunque, che essa arriva quando arriva, sempre che arrivi, come certi treni nella filmografia di Sergio Leone.
Se così non fosse, il Palazzo di Vetro, brulicante, non di ‘piccole api operose’ ma di minimi stercorari, sarebbe crollato ancor prima delle Torri Gemelle sotto il peso insopportabile della sua inanità, ma c’é ancora tempo a disposizione (diciamo qualche decennio) perché, nel piegarsi esanime su se stessa l’ONU si porti via il nome, sconosciuto ai più, del suo segretario generale e soffochi il ricordo dei caschi blu che, nel 1994, si nascosero nelle loro caserme in Ruanda mentre lì fuori gli Hutu disboscavano a colpi di machete la progenie dei Tutzi, teste e braccia mozzate, come grandine in pieno agosto.
Benché l’accattonaggio sia stato depennato, aumme aumme, dal novero dei reati, fa specie – come osserva l’amico Tilgher – l’insistenza con cui l’UNICEF continua a chiedere soldi, quando dovrebbe averne molti di suo. Le persone normali, al solo pronunciare la parola ‘bambino’ si mettono subito la mano in tasca. Un riflesso pavloviano, come quello che obbliga John Wayne ad allungarla sulla pistola quando sente parlare di Indiani. E’ forte, e fa male, tuttavia, il sospetto che l’UNICEF si comporti come la proiezione ortogonale di quella donna piena di stracci che un giorno prestava servizio dalle mie parti ostentando, accovacciata contro un muro, un bambolotto di carne. Un lamento lungo una vita. Una specie di mantra diuretico, come le canzoni di Ligabue: più o meno dalle sette del mattino sino alle tredici e trenta, l’ora in cui smontava, e dagli stracci che scivolavano sull’asfalto si sviluppava Greta Garbo, o forse Sophia Loren, non ricordo bene.
Poi, la FAO, quell’immenso sepolcro che sorge a Roma, nei dintorni del Circo Massimo: li diresti morti, e invece stanno lì in attesa che arrivino i soccorsi, come naufraghi nello spazio. I miei ricordi, sottoposti alla corrosione della vecchiaia, si stringono intorno alla figura di Fidel Castro, che, un giorno, arrivò lì, non mi sovviene se per aiutarli ad uscire dall’abitacolo o soltanto per tenere un discorso. Mi colpì il leader maximo. Per il viso ossuto e per gli occhi grandi che sono una speciale prerogativa dei malati e dei matti. E per la giacca, così grande che poteva entrarci due volte, e ce n’era anche d’avanzo. Ma Fidel era l’unico, in quella distesa di zombi, che poteva raccontare la fame per averla patita sotto Batista e averla infine sconfitta sotto di sé. Era la realtà che si emacipava dalle spire della simulazione e del sogno. Perché -diciamolo chiaramente – la nostra epoca é una replica del secolo diciottesimo, con troppe voci bianche, troppe scimmiette al guinzaglio, troppa cipria, troppi fronzoli, troppe cose inutili.
Va però detto che allora – così lentamente che sulle prime nessuno ci fece caso – si stagliò una sagoma dalle linee molto precise, una composizione essenziale, con un lungo rettangolo, un triangolo e un cerchio.
Era la ghigliottina.